ALBERTO COMUNIAN – PADOVA e ROVIGO
 Alberto Comunian ha una fierezza e un orgoglio che fatica a contenere, anche nell’espressione. Se dovessimo avere un ambasciatore dei valori di caparbietà e fermezza, associate all’onestà e al senso del dovere, sicuramente lui sarebbe tra i primi posti della classifica. Infatti, dice a bruciapelo noi veneti siamo soliti dire: “Fasso tuto mi!”
Alberto Comunian ha una fierezza e un orgoglio che fatica a contenere, anche nell’espressione. Se dovessimo avere un ambasciatore dei valori di caparbietà e fermezza, associate all’onestà e al senso del dovere, sicuramente lui sarebbe tra i primi posti della classifica. Infatti, dice a bruciapelo noi veneti siamo soliti dire: “Fasso tuto mi!”
È stato il fondatore della Associazione Veneta in Cile.
È nato a Rovigo per sbaglio nel 1925, dice, ma si considera padovano, di Arsiero, dove c’era la casa antica della nonna e fu proprio da Padova che emigrò in Cile. Alberto ricorda perfettamente. “L’avvocato Pellizzari presidente della Camera di Commercio di Vicenza e dei Vicentini nel Mondo, mi chiese se conoscevo qualcuno a Vicenza e io dissi che avevo mio cognato Tommaso Franco Valmanara e mi spiegò che in Italia si erano formate le Regioni per competere con l’Europa, e mi chiese di fondare l’Associazione Veneta in Cile formata da un minimo di cento famiglie. Mi sono entusiasmato subito ed accettai di buon grado. Andai immediatamente in cartoleria ed acquistai un registro dove annotare i nomi delle famiglie venete che sarei riuscito a contattare. Ci ho impiegato tre anni. Andai alle scuole italiane, allo Stadio Italiano, uno splendido club dove si ritrovano gli italiani e l’attuale Presidente è Rocco Inserrato, e alla Parrocchia e quando sentivo un nome italiano correvo a chiedere se era veneto e se entrava nell’associazione. Nessun veneto mi ha mai detto di no, non avrei accettato un rifiuto, li convincevo fino all’assenso.
Dopo circa tre anni il mio registro conteneva duecento famiglie. Chiesi aiuto al parroco, per avere un luogo dove incontrarci, alla Parrocchia Italiana dove c’era padre Giuseppe Tommasi. Mi prestò volentieri il luogo e si diede da fare per la causa. Stampammo un invito ufficiale e alla serata dell’11 aprile del 1987 arrivarono circa 300 persone.
Io feci il mio discorso di inaugurazione e costituzione della Associazione e fui eletto Presidente all’unanimità. Nei miei intendimenti, che erano poi quelli dell’Associazione, noi membri dovevamo essere funzionali al Veneto, non solo al Cile. Così, una volta costituita ufficialmente l’Associazione cominciarono ad arrivarmi delle proposte sia dai Vicentini che dalla Regione Veneto. Ad esempio mi arrivò la proposta di organizzare delle trasferte in Veneto per oriundi, con il viaggio pagato a metà, vitto e alloggio gratis durante tutto il soggiorno di quindici giorni. Erano gli anni ‘80. Davano un contributo per ogni ragazzo. Vista la moneta e i prezzi locali, riuscii, facendo delle operazioni di cambio con il dollaro e trattative con l’agenzia di viaggi, non solo a non far pagare niente ai ragazzi, ma alcuni riuscirono a rimanere in Veneto per altri quindici giorni.
Ma parlando di me, mi sono diplomato Perito Tecnico Agrario, specializzato nelle coltivazioni industriali e della barbabietola da zucchero. In occasione della grande alluvione del Po del 1951, mi trasferii in Cile dopo aver ottenuto il beneplacito del Presidente della Repubblica, Gabriel González Videla, al quale mi ero rivolto.
La mia prima attività fu a favore della colonizzazione italiana che si stava realizzando nella zona di Parral. Ma per andare nello specifico, l’azienda CITAL portava i coloni dall’Italia e li facevano insediare in parcelle agricole. Ero il vice amministratore dell’azienda che contava ben 93 mila ettari di terreno. Rimasi con quell’azienda per tre anni. Una volta insediati i coloni italiani, lavorai presso alcuni zuccherifici cileni per la divulgazione della coltivazione della barbabietola da zucchero. Arrivai a Santiago dopo tre anni e in quell’epoca, il governo stava cominciando la divulgazione della coltivazione della barbabietola da zucchero con i relativi zuccherifici per la lavorazione. Cercai di inserirmi in quel settore, che era di mia competenza, ma in Cile tutto si riferiva alla politica. Allora, anche se non conoscevo nessuno, non mi persi d’animo e andai a parlare con l’allora Ministro dell’Agricoltura, perché perdere tempo con altri? Per farmi ricevere mi sono presentato con un po’ di faccia tosta, e una scatola di cioccolatini per la segretaria. Facendo finta di essere atteso le chiesi se il Ministro fosse di discendenza palestinese facente parte di un gruppo numeroso che era fuggito dalla tirannia turca. Così sfruttai il mio cognome, che con tutta probabilità, è di origine armena, Comunian, chiaramente mi ero ben informato prima. Sta di fatto che con questo stratagemma il Ministro mi ricevette e mi accolse come un fratello. Gli Armeni si ricordano bene di essere stati vittime dei Turchi. Il colloquio con il Ministro fu rapido e cordiale, mi chiese se avessi esperienza riguardo alla coltivazione della barbabietola da zucchero e io senza battere ciglio risposi che mio nonno era il principale coltivatore di barbabietola della bassa padovana ed io ero specializzato proprio in quel settore all’università di Ferrara. Con queste credenziali il ministro prese il telefono, parlò col direttore generale del principale zuccherificio del Cile, anche lui di origini palestinesi, e quindi anche lui protetto dallo Stato. Dopo 12 ore avevo già firmato il contratto e rimasi in quell’azienda per quattordici anni. La mia qualifica era Agronomo Etensionista. Il lavoro consisteva nell’assistenza tecnica agli agricoltori e nella promozione della produzione della coltivazione. Devo dire sinceramente che è stato un lavoro che mi ha dato notevoli soddisfazioni.
Nel frattempo mi sono sposato con Ambra Valentino ed abbiamo tre figli: Fiorenza, Leonardo e Flavio. Ma poi volli fare l’esperienza di lavorare in proprio ed acquistai una proprietà agricola.
Per aiutare i miei connazionali mi sono occupato anche della Scuola Italiana, della Camera di Commercio facendo rappresentanza di prodotti italiani in Cile.”
Alberto Comunian è un personaggio che ha avuto una storia da raccontare anche prima dell’emigrazione. Infatti, ha descritto una parte della sua avventurosa vita a Mónica Kast, la quale lo ha trascritto e pubblicato nel testo Testimonios de los sobrevivientes. Chile y la segunda guerra mondial, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, agosto 2005.
Vivevo in un ambiente dittatoriale. Sono nato e cresciuto con Mussolini, con il fascismo. A differenza di quello che si dice adesso che sono passati tanti anni, il fascismo era una forma di socialismo ed è questo che la gente si dimentica e la sinistra non riconosce.
Il fascismo e il nazismo, tralasciando la guerra e i morti, ma considerando quello che venne dopo, furono le uniche due forze che, insieme a Franco, fermarono l’invasione del comunismo in Europa. Senza di esse il comunismo si sarebbe preso tutta l’Europa, Italia e Germania incluse, dal momento che erano distrutte e impoverite dalla prima guerra mondiale. Il comunismo sarebbe entrato tranquillamente se non fossero nati questi due partiti, i quali acquisirono una forza politica di carattere dittatoriale e portarono il paese ad una egemonia di privazioni.
Mussolini, nella sua idea di futuro, voleva creare lavoro e industrie in Italia. L’Italia era un paese povero, soprattutto dopo il disastro della prima guerra mondiale. Con la forza della sua dittatura costruì ferrovie, università, ospedali, e recuperò molti terreni che erano ormai ridotti a pantano trasformandoli in zone agricole molto fertili. Mussolini creò una legge sul lavoro che non esisteva in nessun’altra parte al mondo: istituì le otto ore di lavoro quotidiano – prima erano dodici e non esistevano vacanze, i quindici giorni di ferie all’anno e un giusto salario. Le persone che uscivano dall’università trovavano lavoro immediatamente, perché lo stato si preoccupava di loro.
Da una parte Hitler copiò il sistema politico di Mussolini; dall’altra Mussolini era apprezzato da Churchill con il quale aveva un buon dialogo per questi sistemi di lavoro. Churchill aveva simpatia per Mussolini perché trovava che fosse l’unico modo di far crescere l’Italia. Inoltre fu capace di unire gli italiani: infatti si diceva che gli italiani erano 45 milioni di abitanti e c’erano 45 milioni di partiti politici, ognuno tirava l’acqua al suo mulino. L’Italia si unificò nel 1866, i siciliani con noi veneziani non avevano niente di che spartire, era come parlare di cileni ed ecuadoriani. Per quanto riguarda le tradizioni e la storia eravamo cresciuti in modo diversi.
Noi eravamo della zona veneta, di Venezia, eravamo stati dominati dall’impero austroungarico per circa cento anni. Avevamo più punti in comune con l’Austria che con i siciliani. I siciliani per noi erano arabi, per noi era lo stesso. Lo stesso succedeva con i napoletani. I nordamericani in un film fanno vedere una gondola di Venezia che canta “O sole mio”. Non ha nessun senso, la canzone è napoletana, noi cantavamo altre cose.
E come era la vita sotto Mussolini prima della guerra?
Io posso raccontarla senza confronti. Andavo in collegio, la legge era rigorosa, i treni puntuali, la mobilitazione normale, i testi statali. Avevamo l’obbligo, tutti i sabati pomeriggio, di presentarci in strada o in piazza vestiti da fascisti. Facevamo esercizio con dei fucili in miniatura e marciavamo. Se uno non andava prendeva una nota in educazione fisica e non passava l’anno. Era obbligatorio. Fino a che scoprii una cosa: dove si comprava l’uniforme, mi comprai i gradi. Mia mamma li vide e me li attaccò all’uniforme. Così salii di grado e nessuno mi disse niente e smisi di marciare.
Nel 1943 apparivano i “bandi murali” nelle strade, dei cartelloni di un metro per due con tutti i nomi di quelli che dovevano presentarsi, a prescindere dall’età. La parte inferiore dell’avviso diceva che avrebbero istituito dei gruppi di vigilanza per verificare l’identità dei pedoni, e quelli che pur essendo nella lista non si fossero presentati per punizione sarebbero stati mandati nei campi di concentramento in Germania. Questo gruppo di vigilanza si chiamava la “brigata nera”. Inoltre il bando stabiliva che, se non si fosse presentato nessuno, sarebbe toccato a quello più grande che era in casa, nel mio caso sarebbe toccato a mio padre, dal momento che io ero il maggiore di sette fratelli. E questo non potevo accettarlo. A quel tempo le famiglie erano molto grandi dal momento che Mussolini le aveva sempre incoraggiate per avere più soldati.
In collegio si discusse con tutti gli altri compagni che erano nella stessa situazione. Con i compagni di tutti e due i corsi, in totale eravamo 80. Si decise di presentarsi tutti insieme, e la cosa migliore era farlo alla forza aerea per il servizio che si fa negli aeroporti, senza andare in guerra o fare esercizi violenti. Ci misero sotto il comando della seconda truppa aerea d’Italia, senza avere idea di cosa ne avrebbero fatto di noi visto che eravamo circa 200. Per molti giorni ci tennero in dei grandi capannoni e alla fine ci mandarono nel nord d’Italia in una caserma dove ci impartirono un’istruzione militare per 15 giorni.
Un giorno suonò la diana alle 4 della mattina, ci ordinarono di preparare gli zaini e ci raggrupparono nel cortile in ordine di statura. Poi ci fecero salire su dei camion tedeschi con soldati tedeschi. Chiesi ad un sergente italiano cosa stesse succedendo e lui ci disse che stavamo per passare a far parte della forza aerea tedesca.
Io ebbi fortuna, mi inviarono a Udine, molto vicina a Trieste. Questi soldati tedeschi tornavano dall’Africa ed erano decimati. Avevano i cannoni ma non sufficiente personale. Creammo delle truppe miste, metà italiane e metà tedesche, però con il comando tedesco. Era marzo e da poco avevo compiuto 18 anni.
Lì vivevamo in baracche di legno divise in tre parti che riscaldavamo con una piccola stufa al centro. I comandi tedeschi ci lasciarono in carica un cannone antiaereo trasportabile. C’era bisogno di 6 persone per poterlo maneggiare. Si trattava di un cannone abbastanza piccolo, di 20 mm, con una gittata di soli 1.800 metri, che quindi non serviva a niente contro i bombardieri alleati che volavano sopra i tre mila metri. Inoltre il cannone era lento da manovrare, cosa che impediva di sparare bene in caso di bombardamenti raso terra. Si può pertanto dire che ci fu la guerra ma che allo stesso tempo non ci fu. Allora, dal momento che il cannone era trasportabile, ci inviavano di città in città in base alle necessità, e rimanevamo 15 giorni in un luogo, 20 in un altro. Così mi toccò difendere ponti, aeroporti e così via. Al fiume Po’ ci toccò stare molte volte.
In questi mesi ci insegnarono anche il jujitsu, una via di mezzo tra il karate e il judo. Io diventai cintura nera e dopo, in Cile, a mia volta lo insegnai.
Noi italiani eravamo convinti che la guerra fosse ormai persa. I tedeschi che erano con noi avevano la nostra stessa età. Uno di 24 anni era un veterano, un capo tedesco di 24 anni aveva già fatto la guerra in Africa e la campagna italiana, per cui questi erano veterani completi. Il cibo era tedesco e abbastanza ricco di calorie. Dormivamo in tendoni, all’aria aperta, facevamo esercizi, ogni tanto sparavamo. La mia famiglia mi scriveva preoccupata ma io dicevo che stavo bene, che non avevo problemi e non ero in pericolo. Ero molto ingrassato, mi chiamavano il parroco.
Voglio chiarire una cosa: com’era vivere con i tedeschi. Durante i bombardamenti noi aiutavamo a soccorrere i feriti e i mutilati, tedeschi o italiani che fossero. Io ero l’aiutante di un infermiere tedesco. Per esempio, se a uno gli tagliavano una gamba io lo tenevo fermo mentre l’infermiere gli legava le arterie e tutto il resto.
Posso assicurare nel modo più assoluto che i soldati tedeschi, non le SS né i nazisti, ma la truppa per intendersi, non avevano la più vaga idea dei campi di concentramento. Neanche noi in Italia. Tutto questo si seppe dopo. Quando loro tornarono in Germania, devono essere stati molto afflitti: oltre ad aver perso la guerra, si resero conto di tutto quello che era successo.
Faccio un esempio. Ad un certo punto, verso la fine della guerra, per tutte le cose che facevamo: fare buchi, preparare il cannone, disarmarlo, spostarlo, mettere le munizioni, ecc., mi venne un’ernia inguinale, che fu provvidenziale. Chiesi allora una visita medica. Domandai al medico se fosse possibile, dal momento che mi dovevano operare, essere mandato in un ospedale feldlazarett, un ospedale militare. Riuscii ad essere mandato in un ospedale militare a 20 chilometri da casa mia. Era un antico palazzo italiano trasformato in ospedale per poter accogliere la gente. Si trovava a Caldogno e probabilmente era una villa del Palladio.
Lì c’erano molti ammalati e, mentre aspettavo il mio turno per essere operato da un chirurgo tedesco, ci fu il famoso bombardamento della città di Vicenza in cui morì molta gente. I feriti riempirono l’ospedale. Così invece di essere operato mi toccò aspettare che curassero gli altri pazienti e a mia volta dovetti dare una mano come infermiere. Provai un’angoscia tremenda. Per esempio, un uomo perse l’udito perché l’esplosione gli fece scoppiare i timpani. Il caso più grave era un uomo che aveva perso l’udito, la vista, entrambe le braccia e le gambe, praticamente era un tronco. C’era un’infermiera tedesca che dimostrava molta passione, credo che quella donna che era anche a capo delle infermiere lavorasse 20 ore al giorno.
E alla fine la guerra terminò; da un mese avevo compiuto 20 anni. Così a 20 anni e un mese ero già un veterano di guerra.
E cosa hai fatto quando la guerra finì?
Vicino a Vicenza, nelle Alpi, c’era la vecchia casa di mio nonno materno. Dal momento che stavano bombardando le città, la mia famiglia si era rifugiata là. Perciò tornai a casa. Era abbastanza grande perché ci vivevamo in 22 senza pestarci i piedi. Durante la prima guerra mondiale questa casa fu occupata dal comando italiano contro gli austriaci. Si trovava molto vicino alla frontiera, a soli 20 chilometri. Quando tornai in questo paese di 5.000 abitanti a 25 chilometri a nord di Vicenza chiamato Arsiero si parlava di assalti nelle case, di furti di animali. Arrivavano piccoli camion per animali puntando le armi per rubarli. Non c’erano né la Polizia né i Carabinieri, perché quando il Re se ne andò anche quelli che gli avevano giurato fedeltà se ne andarono.
Allora io con altri undici giovani che si trovavano nella mia stessa situazione abbiamo formato una Polizia. Ci siamo inventati un’uniforme con dei vestiti. Dal momento che io ero il più “studioso” mi misi il grado di tenente. Ci chiudemmo dentro al Comune e così facevamo anche da Sindaco risolvendo i problemi.
E gli alleati non erano arrivati?
No, ancora no. Arrivarono sei mesi dopo. Credo che anche a Vicenza non fossero ancora arrivati.
A un certo punto, dopo che avevamo formato la nostra Polizia, arrivò un gruppo di gente, che non era fascista, con la lista delle persone che bisognava fucilare per diversi motivi. Lessi le motivazioni e, per esempio, uno voleva fucilare un altro perché molti anni prima non aveva finito di pagare una mucca che gli aveva venduto. Allora io dissi; “d’accordo, ce ne occupiamo noi”. Parlai con i ragazzi che erano con me e mandai a prendere i dodici uomini condannati a morte. Li mettemmo in un’aula della scuola che faceva parte del nostro Comune. Comprai un quaderno e alcune matite e dissi loro che ognuno doveva riempire una pagina del quaderno scrivendo alle mogli che portassero un cuscino, una coperta pesante, cibo per tutti i giorni, le carte e qualche altro gioco. Rimasero chiusi lì tre mesi, eppure li avrebbero uccisi perché li potevano aspettare fuori di notte per ammazzarli.
Quando arrivarono gli alleati apparvero in due jeep. Avevamo un allarme dato dal campanile che suonava in maniera diversa. Siccome dall’alto si vedeva la strada a distanza di chilometri, ci accorgemmo subito dell’arrivo dei due veicoli. Ci preparammo: io mi misi nella porta del Comune, ero armato e lo erano anche i miei compagni. Arrivò la primo jeep dalla quale scesero alcuni nordamericani disarmati, uno era un ufficiale. Dietro veniva l’altra jeep guidata da un nordamericano e tre carabinieri. L’ufficiale scese e chiese chi comandava lì. Io lo guardai, estrassi la pistola e gli dissi: “lei”. E me ne andai a casa.
Dopo ottenni un riconoscimento per il servizio militare e mi diedero un salario.
Quello che posso dire è che io sono stato con tedeschi, francesi, inglesi e nordamericani e, una volta terminata la guerra, ci siamo considerati colleghi. Non è che uno si alza una mattina, prende un fucile e dice: “oggi faccio la guerra a questo paese”. È il governo, il sistema politico. Io sono uno che segue la sua Patria
E come venivano considerati i tedeschi e gli alleati durante la guerra?
All’inizio della guerra tedeschi e italiani erano una cosa sola. Alla fine invece gli italiani erano divisi; solo pochi seguivano ancora i tedeschi perché era venuta alla luce la questione dei campi di concentramento e questo cancellò tutto.
In seguito venni a sapere che un amico mio, scartato al servizio militare perché fisicamente debole, durante una retata fu preso e portato in un campo di concentramento in Germania, dove morì di inanizione perché non aveva forza fisica.
Un ufficiale dei carabinieri, che aveva sposato una mia cugina, lavorava proprio al confine tra Austria, Italia e Yugoslavia. Arrivarono i tedeschi e gli diedero degli ordini ma lui si rifiutò dicendo che era italiano e che obbediva solo al Re. Allora lo portarono in un campo di concentramento e lì cercarono di fargli cambiare idea con la violenza. Lo uccisero a bastonate. Queste cose vennero fuori dopo perché qualcuno si salvò e tornò a raccontarle. Quando la guerra finì, credo che quasi il 90% degli italiani era contro il sistema nazista, non contro i tedeschi, ma contro il sistema. Una cosa è la persona, un’altra è la politica.
E gli alleati, come li consideravi?
Io ho la mia personale opinione. Per esempio, ti parlo di Montecassino. È un monte con un monastero immenso, molto bello e antico. Lì si trovava la biblioteca più antica d’Europa. Montecassino dominava la valle che lo circondava. Gli alleati passarono Roma e il 4º esercito si incamminò per la valle di Montecassino ma non riuscì ad attraversarla a causa della resistenza che facevano i tedeschi. Ma quelli che facevano questa resistenza erano i falschojaeger, i paracadutisti, le forze d’élite dei tedeschi. Ognuno di loro viveva in un buco del terreno e gli lanciavano il cibo durante la notte. La maggioranza aveva carabine, non armi pesanti. Erano dei tiratori così bravi che bastava che un nordamericano avvicinasse la testa del carro armato e lo uccidevano. E il carro armato restava lì. Il generale Clark, nordamericano, arrivò alla conclusione che sopra, a Montecassino, dovesse esserci un centro di controllo tedesco e ordinò di bombardare Montecassino, dove invece non c’era nessuno. Lo distrusse perché era un incapace.
Gli alleati, invece di sbarcare nel centro Italia e tagliare in due l’esercito tedesco, sbarcarono al sud e salirono un po’ alla volta, con calma; hanno sempre cercato di non sacrificare uomini, perché le macchine e le armi si possono ricostruire, ma il capitale umano no. Usavano un sistema di bombardamento a tappeto: se dovevano colpire un punto determinato, iniziavano a bombardare molto prima e molto dopo. In questo modo erano sicuri di aver colpito il punto predefinito, ma avevano bombardato anche tre volte prima e tre volte dopo questo punto. Senza motivo distrussero chiese, ospedali, università, opere d’arte; distrussero tutto. A Berlino, dopo la guerra, solo alcuni muri rimasero in piedi. Anche in Italia fu in parte così. Non si può dire se fossero buoni o cattivi combattenti, come nel caso di Okinawa in oriente. In Europa prima bombardavano tutto, poi inviavano i carri armati e solo dopo venivano i soldati.
E come è arrivato in Cile?
Eravamo sette fratelli. Mio padre era socio in un’azienda di impianti di gas metano. Iniziò prima della guerra e durante la guerra continuò a consegnare bombole di gas metano a camion, auto, imbarcazioni di pescatori, mantenendoli così attivi. Finita la guerra, arrivarono i partiti politici e con i partiti arrivarono i golosi. A noi toccò la democrazia cristiana. Un signore democristiano iniziò a statalizzare tutto. Poi ci fu l’alluvione del Po e l’industria andò sotto acqua, 21 pozzi sotto acqua. Fu una cosa tremenda. Imposte interne si aggiungevano ad altre imposte su qualcosa che non avevamo. Allora io decisi di andarmene a cercare nuovi orizzonti.
Un mio amico che era partito per il Sudafrica mi dava buone notizie e diceva che gli regalavano la terra. L’Australia era molto lontana e oltretutto parlavano inglese. In argentina c’erano molti italiani e pensai che non mi conveniva. Volevo andare in un posto dove ci fossero pochi italiani perché altrimenti sarei diventato uno del gregge. Decisi allora per il Canada. In quel momento lessi in una rivista di una colonizzazione che il governo cileno stava facendo con gli italiani, una a La Serena e una a Parral. Si parlava del Cile, ma chi lo conosceva il Cile? La Bolivia era conosciuta, ma il Cile no. La Bolivia era conosciuta perché costituivano il governo una volta all’anno, poi si stancavano e lo buttavano dalla finestra. Il Cile, tranquillo, nessuno ne parlava. Si sapeva solo che era un gran produttore di salnitro e che aveva una capitale molto bella chiamata Valparaíso. Ma da quando lessi quella rivista, con tutti i nomi e le fotografie, iniziai a informarmi sul Cile nell’enciclopedia e nelle cartine geografiche.
Andai al consolato cileno a Milano. Mi ricevettero con gentilezza, parlammo e mi chiesero se conoscevo qualcuno in cile o se avevo un contratto di lavoro in Cile. Dissi di no. Allora mi risposero che non potevano darmi il visto perché per ottenerlo c’erano due requisiti: o ci sono due persone che rispondono per te o hai un contratto di lavoro.
Mi andò male. Allora tornai a casa e, rileggendo la rivista, notai che si diceva che questa colonizzazione italiana era patrocinata da un tale Gabriel González Videla. Pensai che doveva essere una persona conosciuta. Decisi di scrivere una lettera a Gabriel González Videla, Santiago del Cile. Gli spiegai che ero italiano, quello che avevo fatto, che ero agronomo e che mi sarebbe piaciuto andare a vivere in Cile. Inviai la lettera per nave e dopo un paio di mesi mi chiamò al telefono di casa il console cileno di Milano. “signor Comunian”, mi disse:“che cosa ha fatto?”, “niente di male” risposi: “perché dice questo?”. Mi disse che aveva ricevuto istruzioni da parte della cancelleria cilena di aiutarmi in ogni modo. Mi chiese di andare al consolato e gli risposi che sarei andato il giorno seguente. Presi il treno a Padova e andai a Milano. Entrai, il console mi fece sedere, si fermo e mi guardò dicendo: “mi può spiegare quello che ha fatto? Io qui ho un ordine perentorio.” Allora gli raccontai il fatto e lui scoppiò a ridere. Mi timbrò il passaporto e mi disse che potevo partire quando volevo. E partii. Dal momento che la mia famiglia era benestante, me ne andai in prima classe. Mi imbarcai a Genova, la nave faceva il giro per il canale di Panama e iniziò a scendere un po’ alla volta. Era il 1951.
Il primo porto del Sudamerica che toccammo fu La Guaira, in Venezuela. C’erano gruppi di neri sdraiati per terra, dov’era tutto sporco. Come sono indietro, pensai. Siccome la nave rimase ferma lì un giorno scendemmo per conoscere un po’ il posto. Poi arrivammo a Panama; lì ci dissero di scendere a gruppi di 5 o 6 altrimenti ci avrebbero assaliti e derubati. Un’altra impressione del Sudamerica. Continuammo a scendere e arrivammo al porto di Barranquilla, anche lì tutti neri. Anche lì scendemmo mentre la nave scaricava la merce. Passeggiando per il porto ci dissero di far attenzione con le donne. Non capivo perché, erano nere di bell’aspetto, longilinee. Ci dissero che prima attiravano gli uomini poi li assalivano. Anche qui era tutto molto sporco. Un altro porto fu quello di Callao in Perù. La prima impressione di questo paese fu un odore puzzolente, di sporcizia, di povertà, di umidità. La gente stessa era brutta; il senso estetico lo abbiamo in Europa. Più scendevamo e più era peggio, arrivati alla fine tornerò a casa, pensai. E andai avanti.
Arrivammo ad Antofagasta di notte. Quando mi svegliai e guardai fuori dalla finestra, quasi non ci credevo, visto tutte le cose che avevo visto fino a quel momento. Vidi il deserto e un’oasi verde con le case così come ero abituato a vederle e non capanne. Mi vestii in fretta e con due amici scesi ad Antofagasta. Contrattammo con un taxi che ci portò a fare un giro per la città, poi rimanemmo seduti in piazza a guardare la gente, perché il fattore umano ha sempre avuto molta importanza per me. Vidi belle donne, e allora dissi: “qui ci troviamo già bene”.
Dopo arrivammo a Valparaíso, a mezzogiorno. Si vedeva tutta una costellazione di case multicolore, l’ingresso al porto in qualche modo mi ricordava Genova. Scendemmo a Valparaíso dove c’era un controllo tremendo perché c’era molto contrabbando. Alla dogana i funzionari mi aprirono la valigia e il baule. Trovarono il mio fucile e mi fecero delle domande a riguardo. Io dissi che era mio e mi contestarono il fatto che era nuovo; allora io risposi: “ma volete che emigri con il fucile vecchio?”. No, e allora me ne sono comprato uno nuovo. Nel frattempo, l’altro funzionario mi stava controllando il passaporto; lo guarda e dice all’altro che io avevo un visto ordinario. Questo si fermò di colpo e mi disse di chiudere tutto e di procedere. Presi una stanza in hotel e poi andai al Consolato Italiano a chiedere cosa avesse di straordinario un “passaporto ordinario”. Mi dissero che significava “persona gradita al paese”. Pensa come entrai in quel paese.
Dopo mi incamminai per conoscere Valparaíso e in una piazza carina, verde, fui attratto da delle orchidee e dal fatto che erano in vista. In Italia non ne sarebbe rimasta nessuna, la gente le avrebbe portate a casa. Era il 22 dicembre, mancavano solo tre giorni a Natale. Mi venne sete ma guardandomi intorno non vidi nulla che sembrasse un bar. Guardai dentro ai locali e vidi che in uno c’erano delle bottiglie. Fuori c’era scritto un nome strano: Fuente de soda. Fontana della soda, pensai; e allora entrai. In un angolo del bancone c’era un grande vaso di vetro, tipo un barile. Era freddo e notai che era latteo, pensai che fosse latte con cannella. Ne chiesi alla signora un bicchiere. Era buono, e allora ne chiesi un altro e poi pagai. Quando provai a camminare quasi non sentivo le gambe. Era cola de mono (una bevanda tradizionale cilena i cui principali ingredienti sono caffè, latte, grappa, zucchero e cannella!) Riuscii ad arrivare in hotel dove dormii fino al giorno seguente.
E rimase a vivere a Valparaíso?
No, il giorno seguente andai a Santiago, dove sapevo che c’erano degli amici dei miei genitori. Mi ero messo d’accordo con uno di loro perché mi ospitasse per un po’, perché aveva un appartamento con una stanza libera.
Quando arrivai col treno alla stazione di Mapocho presi un taxi e diedi indicazioni all’autista di fermarsi in Avenida Santa María. Ma lui andò verso il centro e fece un giro enorme. Dopo mezz’ora arrivammo in Avenida Santa María e quando mi girai vidi la stazione. Mi prese in giro ma dovetti pagargli tutto.
LEONARDO COMUNIAN e CLAUDIA ZECCHETTO
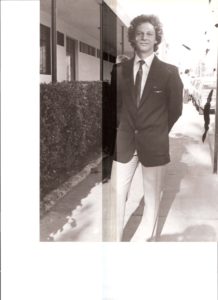 Leonardo ci racconta: “Sono nato a Santiago il 21 luglio del 1964 mio padre e mia madre sono entrambi italiani emigrati in Cile, dove si sono conosciuti e sposati. Sono nato quindi in una famiglia dove si parlava solo l’italiano, da piccolo parlavo lo spagnolo solo con la donna di servizio, infatti, quando andai a scuola mi dissero che in spagnolo ero scadente. Ho dovuto imparare lo spagnolo a scuola.
Leonardo ci racconta: “Sono nato a Santiago il 21 luglio del 1964 mio padre e mia madre sono entrambi italiani emigrati in Cile, dove si sono conosciuti e sposati. Sono nato quindi in una famiglia dove si parlava solo l’italiano, da piccolo parlavo lo spagnolo solo con la donna di servizio, infatti, quando andai a scuola mi dissero che in spagnolo ero scadente. Ho dovuto imparare lo spagnolo a scuola.
Mi ricordo che ad un certo punto ci trasferimmo da Santiago a Pomaire, vicino Melipilla, circa novanta chilometri da Santiago, dove mio padre aveva acquistato un podere. Si coltivava frutta, agrumi, mais, patate, erano circa 100 ettari. Avevo sei anni e ho cominciato a frequentare lì la prima elementare, mi ricordo il trauma perché parlavano in una lingua che non era la mia. Poi venne il regime di Allende e una legge diceva che i poderi non coltivati dovevano essere espropriati per il bene sociale. Sebbene il nostro podere fosse completamente coltivato ci venne espropriato. Fu data la terra al popolo e l’unico risultato fu che nessuno più lo coltivò. Tutto il nostro lavoro andò in malora. Anche se ero piccolo mi ricordo perfettamente tutto. Quando arrivarono per toglierci la terra presero il maiale che avevamo affittato per la riproduzione, che costava tanto quanto la casa, e lo fecero arrosto. Il giorno prima eravamo felici a casa nostra, il giorno dopo eravamo in macchina senza niente. Quindi, solo con gli effetti personali che ci lasciarono andammo a Santiago da mio nonno che aveva una casa in costruzione siccome non era finita dovemmo dormire tutti insieme.
Comunque i miei migliori ricordi sono in campagna, adoro l’aria aperta. Ora vivo a Valparaiso. Mio padre era fissato con la lingua italiana e in realtà mi diceva sempre: “Dimmi una parola e vedrai che ha origine latina”. Per non parlare poi del dialetto veneto. Infatti, diceva che Dante era in Veneto, quando decise di scrivere la Divina Commedia ed era sul punto di scriverla in veneto, ma poi all’ultimo optò per la sua lingua madre, il toscano. Con questi presupposti andai alla scuola italiana e frequentavo sempre altri italiani. Nel 1982 andammo in gita in Italia per un mese, con la scuola, a 17 anni, da Torino fino a Paestum e cinque giorni a Parigi. Sono stato anche a trovare i parenti, alla fine non volevo più tornare a casa, mi sono trovato benissimo. Quando ritornai mi dissero che avevo addirittura acquisito la cadenza del dialetto veneto! Un momento emozionante è quando andai a fare visita alla sorella di mia nonna, 106 anni, Lavinia Pivari. Appena m vide non mi riconobbe, ma dopo pochi minuti scrutandomi meglio cominciò ad urlare: “Ze il putin d’Alberto! Le si gonfiarono tutte le vene del collo che io presi una tale paura che mi morisse tra le braccia d’infarto. Mi stupii quando mi mostrò tutte le foto mie e della mia famiglia che aveva e tutto quello che conosceva di me, conosceva ogni minimo dettaglio.
Per capire cos’è la tanto osannata cultura italiana, devi andare ad assaporarla, altrimenti non riuscirai ad entrarci pienamente. Mi sono stupito della libertà che c’è in Italia. Se pensi una cosa la puoi dire liberamente, non devi stare attento a cosa e come, là puoi parlare direttamente. Infatti, nel ‘82 il Cile era un paese “chiuso”. Ora le cose per fortuna sono cambiate.
Quando mio padre fondò l’Associazione Veneta in Cile, noi giovani cominciammo ad avere delle opportunità. Così grazie ad un progetto della Regione Vento che metteva a disposizione dei finanziamenti per i giovani oriundi ci fu la possibilità di andare a visitare la regione dei loro genitori o nonni. Partimmo in undici e ritornammo in dieci. Uno di noi, Italo Celli, non ne volle sapere di ritornare indietro, e vive tuttora a Bassano. Prima di partire ci fu una riunione organizzata da Aldo Rozzi Marin, che già allora si dava un gran da fare per il Veneto, e fu lì che conobbi mia moglie, Claudia Zecchetto. Tutto cominciò in una discussione, mentre stavo facendo vedere le foto del mio precedente viaggio in Italia mostrai Montagnana e lei mi disse che mi sbagliavo e che quella città era Marostica. Lei insisteva, ma era impossibile visto che le foto le avevo scattate io e non ero mai stato a Marostica. Lei non voleva crederci e dovetti mostrarle altre foto per convincerla. Poi comunque riuscii a persuaderla nel farla diventare mia moglie. L’essere veneto, e italiano, per me significa non solo avere il passaporto italiano, ma sapere la lingua, conoscere la cultura. La Regione Veneto fa bene a interessarsi in maniera importante con i “suoi figli nel mondo”, se non altro come segno di riconoscenza per tutto quello che hanno fatto gli emigranti nel dopoguerra nel mandare le rimesse in madrepatria. Sento una stretta al cuore, quando sento questa mano tesa della Regione verso di noi.”
Claudia Zecchetto
Ci racconta: “Sono nata a Santiago nel 1964. Mio padre è nato in Italia, ad Isola della Scala. Io, comunque, mi sento veneta perché mio padre mi ha sempre parlato dell’Italia. Posso dire di aver avuto un’infanzia felice, qui in Cile, abitavamo vicino ai monti, a Rancagua. Andavo in giro in bicicletta e a settembre andavamo a far volare gli aquiloni. Mi ricordo che a Natale c’era il momento magico. Tutta la famiglia si riuniva. Noi bambini uscivamo in macchina col papà per andare a scovare dov’era Babbo Natale. Fermavamo le persone per la strada e mio padre chiedeva se avevano visto Babbo Natale e chiunque fosse rispondeva che era appena passato. Andavamo anche a suonare i campanelli delle case per fare la stessa domanda ed avevamo sempre, con gentilezza, la stessa risposta, o che era nella casa successiva. Dopo alcune ore, sconsolate di non aver rintracciato Babbo Natale ritornavamo a casa e guarda caso era appena andato via lasciando tutti i regali per noi. Eravamo felicissimi. Circa fino ai dieci anni siamo andati alla ricerca di Babbo Natale.
Quando avevo ventitré anni andai in Italia per la prima volta. Ero emozionatissima. A Verona ho provato una stretta al cuore. Nel momento in cui ho visto per la prima volta lo zio Ferruccio, l’ho riconosciuto immediatamente come uno di famiglia, era identico a papà. Anche lui era veramente felice di potermi abbracciare. Andammo a pranzo con tutta la famiglia ed io rimasi impressionata perché mi portarono sette portate. In Cile sono al massimo tre. Ma il momento migliore venne dopo, quando salimmo sul ponte di Bassano del Grappa con un amico. Di colpo mi vennero in mente tutte le storie che mi aveva, negli anni, raccontato il nonno. Le vicissitudini delle guerre. Fin da piccola avevo ascoltato i cori degli alpini. Ancora oggi conosco a memoria la melodia di “Quel mazzolin di fiori” o della “Montanara”.
Tratto dal libro “Destinazione Cile” di Flavia Colle e Aldo Rozzi Marin, pubblicazione promossa dalla Regione del Veneto, Assessorato ai Flussi Migratori e realizzata dall’Associazione Veneti nel Mondo, in partenariato con l’Associazione Veneta del Cile e l’Associazioni Imprenditori Veneti in Cile. (Tipografia Grafica Corma – Grisignano di Zocco, Vicenza. Maggio 2008)


